Luoghi - Nuovo sito Illorai
Illorai
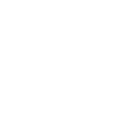
Illorai
      | L'itinerario è incentrato sulla necropoli di Molia Nell'area circostante, infatti, a 600 m circa in direzione Est, è stato individuato solo un altro monumento di difficile classificazione: un "circolo" megalitico del diametro di circa 30 m, situato alla base di un costone tufaceo. La necropoli, scoperta nel 1976 durante i lavori di costruzione della strada Benetutti-Borore, comprende nove ipogei in forte degrado, scavati nel lieve declivio di una collina di tufo <Fig. 36>. Due di questi ipogei, il I ed il VII, possono essere considerati come tra i più articolati e vasti ipogei non solo della Sardegna ma anche del Mediterraneo. Trovano puntuali affinità con il ben noto ipogeo di Hal Saflieni a Malta. La tomba I è costituita da un "drornos" o corridoio a cielo aperto, da un'anticella semicircolare e da almeno undici celle successive. Del dromos sono state individuate le tracce per una lunghezza di m 24, una larghezza media di m 4 ed un'altezza di m 0,60. L'anticella, di forma semicircolare, misura m 10,50 di diametro e rivela tracce cospicue di uno strato di malta dipinto di rosso-ocra e di grigio. Alcuni campioni d'intonaco sono stati sottoposti ad analisi. La tomba VII si distingue per la raffinata esecuzione, per la presenza di numerosi elementi architettonici come lesene, architravi, banconi e per la colorazione in rosso presente in tre vani. L'esame dell'abbondante e ricco materiale archeologico restituito dagli scavi condoni in diverse campagne Tanda 1976-77, 1982 e 1983> rivela che la necropoli è stata utilizzata a cominciare dalla fine 4e1 IV millennio a. C., con la cultura di Ozieri e successivamente durante le culture di Filigosa, Alealzu, Campaniforme, Monte Claro e Bonnanaro, fino all'età. punica e romana. Gli scavi della tomba I hanno anche restituito numerosi campioni paleobotanici, che sono stati analizzati. Appresso è riportata la sintesi dei risultati delle analisi dei reperti paleobotanici e dell'intonaco. Indagine ininemiogica Lo studio mineralogico del campione è stato finalizzato alla determinazione della composizione dell'intonaco, prendendo come termine di paragone la. roccia sulla quale era stato applicato l'intonaco stesso. Ciò ha permesso di arrivare alla classificazione litologica della roccia e di stabilire la natura dell'impasto costituente l'intonaco e la sua provenienza. I metodi comunemente usati per il riconoscimento e la classificazione dei minerali sono stati applicati al campione dopo averlo tagliato e ridotto in sezioni sottili. Tali sezioni sono state esaminate al microscopio mineralogico a luce trasmessa. Il campione è risultato essere costituito da seguenti strati: A roccia; B impasto a matrice grossolana; C impasto a matrice più minuta; D pigmento rosso. I dati ricavati dallo studio delle sezioni rivelano clic lo strato A, per le sue caratteristiche mineralogiche e. modali, può essere classificato come appartenente ad un tufo riolitico o riodacitico. Gli strati li e C, essendo composti da associazioni mineralogiche coincidenti con lo strato A ma con struttura pavimentosa e orientazione a caso dei cristalli, sono presumibilmente derivanti dalla macinazione e trasformazione di roccia tufacea dalle caratteristiche simili a quella sottostante. Pertanto appare ragionevole affermare che il materiale utilizzato per fare l'intonaco della domus campione è di origine locale. Indagine chimica Le analisi chimiche eseguite su cinque campioni tendevano ad accertare: 1. la composizione e la provenienza dei materiali utilizzati per la preparazione dei diversi strati d'intonaco; 2. la composizione dello strato pittorico. Per tale scopo sono state utilizzate diverse tecniche strumentali e precisamente, per le indagini sull'intonaco: - analisi speflrografka - diffrazione di raggi X - analisi termogravimetrica - analisi termica differenziale - spettroscopia infrarosso Per l'analisi dell'intonaco sono stati esaminati cinque campioni: 1. intonaco superficiale (strato sottile) 2. intonaco 3. roccia (parete di supporto) 4. roccia degradata 5. argilla Le analisi spettrografiche mostrano che, per gli elementi principali, i campioni 1-3 <sui rimanenti non è stata finora eseguita), hanno la stessa composizione qualitativa. Le analisi per diffrazione di raggi X indicano che nei campioni I 3, sono presenti gli stessi componenti cristallini sebbene in proporzioni diverse nel campione 3 rispetto ai campioni I e 2. Le analisi termogravimetrica e termica differenziale mostrano per i campioni i e 2 una piccola e costante perclita in peso senza mostrare alcuna trasformazione tale da far pensare alla presenza di carbonati di calcio. In base a questi datti si può ritenere che i due strati d'intonaco siano stati realizzati con lo stesso materiale e che non sia stata usata calce come legante. Gli spettri IR eseguiti sui campioni 2-5 vengono confrontati con lo spettro di una calce-bentonite. Dalla comparazione delle zone caratteristiche si può ritenere che: 1. l'intonaco sia costituito da un'argilla di tipo bentonitico cui è stato aggiunto altro materiale per rendere l'argilla più lavorabile; 2. l'argilla usata potrebbe provenire dalla trasformazione della stessa roccia in cui è stato scavato l'ipogeo. Dall'osservazione al microscopio si rileva che lo strato pittorico è costituito da un unico strato di pigmento rosso applicato sull'intonaco. In base ai dati dell'analisi spettrografica e dello spettro infrarosso tale strato risulta essere formato da ossidi di ferro e silicati comunemente definiti ocra rossa. Analisi paleobotaizica Le analisi dei circa 400 campioni restituiti dagli scavi sono state condotte presso i laboratori:.dél Dipartimento di Biologia Vegetale dell'università "La Sapienza" di Roma e presentate da L. Sadori - G. Tanda - M. Follieri al Congresso della Società Italiana di Botanica del 1989. I macrofossili vegetali, legni e. cariossidi carbonizzati, erano indugi in sedimento concrezionato proveniente dalla terra di scavo. I frammenti di legno carbonizzato sono attribuibifi a Quercus iter e ALntw sp. Sono state identificate cariossidi di Triticitin acstivi.£,n/dttrutn e Hordetetn Sp. Tutti i reperti paleobotanici provengono dall'antic ella della tomba e sono stati rinvenuti vicino a frammenti di vasi riferibili a corredi funerari di cultura Ozieri (Neoliticò recente, 3200-2500 a.C.). | |
Di Cristoforo Puddu ( Sabato 10 Gennaio 2015) Sono ripresi gli scavi nella necropoli prenuragica di Illorai. L’eccezionale e casuale scoperta di una necropoli in regione Molia nel territorio di Illorai (SS), nel 1976, durante i lavori di sbancamento di una collinetta tufacea per la realizzazione della strada Ottana-Iscra-Benetutti ( SP 153 Borore-Olbia), riconducibile al periodo prenuragico di San Michele d’Ozieri, permette di attestare la presenza dell’uomo nel territorio sud-orientale del centro goceanino a partire dal Neolitico Recente (3800-2900 a.C.). All’epoca, nel 1976 e nel 1977-1978, furono effettuate due distinte e modeste campagne di scavi per conto della Soprintendenza ai Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro che rivelarono delle tombe uniche nel loro genere in Sardegna, con dromos, cioè corridoio, realizzate con tecnica perfetta e ottime linee architettoniche. Pareti, soffitti e pavimentazione delle domus, sono estesamente tinteggiati con un’ocra rosso brillante. Vi sono stati ritrovati vasellami, frammenti di ceramiche, di macine e corredo funerario costituito da utensili fittili. La necropoli di Molia a richiama a confronto i noti monumenti maltesi di Taxin e Al Saflieni. Interessanti, negli anni, gli scritti e qualificati contributi della nota archeologa Giuseppa Tanda (si vedano, tra gli altri, le considerazioni sul sito archeologico di Molia nella pubblicazione dei Quaderni bolotanesi n.6, 1980) e le preziose note contenute nella tesi di laurea della giovane archeologa illoraese Sara Mameli che hanno tenuto vivo l’interesse verso le domus de janas di Molia. Ora, a distanza di oltre trentacinque anni dagli ultimi scavi sono ripresi i lavori, sul finire del 2014, e per il biennio 2015-2016 sono programmate ulteriori indagini archeologiche. Le campagne di scavo, sotto la direzione scientifica della professoressa Tanda, sono fortemente volute dal Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari e dal Comune di Illorai. L’amministrazione locale, con nuove scoperte, auspica di poter consolidare il già ricco patrimonio archeologico composto per l’età nuragica da ben 27 nuraghi monotorre e complessi, localizzati principalmente nel settore territoriale montano nord-occidentale, e per il periodo giudicale dal caratterizzante ed importante monumento di Pont’Etzu sul fiume Tirso, del secolo XIV e tradizionalmente attribuito ad Eleonora d’Arborea. | ||





